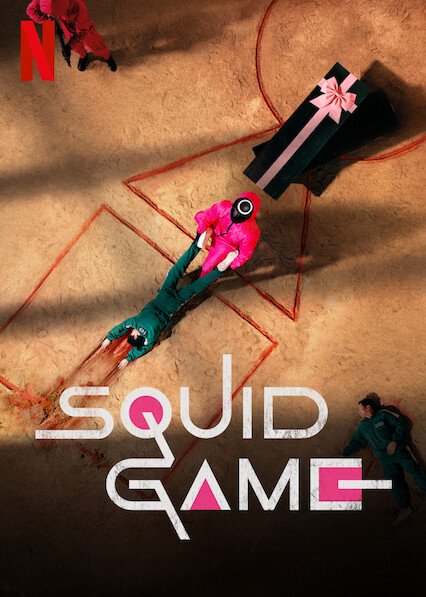In sala dal 22 marzo la nuova pellicola di Sean Baker. Racconto di formazione infantile e deformazione della figura di madre a tinte rosa.
Dopo il conclamato Tangerine, dipinto povero in grado di restituire tutto il grottesco del mondo della prostituzione transessuale americana, Sean Baker torna alla carica con “Un sogno chiamato Florida”. Ancora una volta il giovane autore statunitense afferma la sua estrema sensibilità, la vicinanza e la capacità di appiattirsi su realtà vive e vegete ma troppo underground per vedere la luce, recluse nel sottosuolo sociale.
Baker inventa un gioco dei contrari, costruisce un luogo entro cui far centrifugare realtà diverse ma vicine, forse troppo. Il motel che fa da scenografia all’intera pellicola, presentato in tinta rosa ovattato, è un edificio costruito per assicurare alloggi ai turisti in visita al vicinissimo parco Disney a pochi isolati di distanza. Ma l’hotel della Seven Dwarf Lane in Orlando non ospita solo famiglie in gita turistica. Le stanze sono occupate da mamme single, sfollati e disoccupati senza lavoro, criminali e figure poco raccomandabili. In un’atmosfera bipolare, sono i più piccoli a vivere la lacerazione tra due mondi compresenti, divisi da una singola strada americana trafficata.
In The Florida Project i castelli rosa non sono abitati da principesse dalle scarpette di cristallo. Sono i bambini a crederlo durante il momento del gioco. Ma gioco è anche appostarsi su una finestra e lanciare insulti ai turisti in visita, sotto lo sguardo adirato del direttore del Motel Bob, uomo paziente i cui ultimatum posti come spada di Damocle sulla testa della madre single Halley ,vengono puntualmente rimandati e posticipati a date successive.
Halley non è in grado di mantenere nessun posto di lavoro. Con una figlia piccola, dedica le sue serate allo sballo, l’alcol e le droghe. La piccola Moonee dice di sapere sempre quando un adulto sta per piangere. La sensibilità di una piccola peste va a braccetto con il suo spirito intraprendente, mettendosi a capo di un trio di piccole teste in grado di causare problemi, a volte di incredibile portata.
Scandito su tue ritmi differenti, se in una prima parte della pellicola la piccola Moonee e sua madre sono in grado di sfidare il mondo e prendersi beffa di esso, ignorando le comuni regole sociali, nella seconda parte il riscontro con la realtà del mondo è inevitabile, duro e doloroso. Non pagare l’affitto e lasciar vivere un minore nel degrado della periferia di Orlando non può non essere seguito dalla perdita della custodia. Banalmente, se solo sull’orlo della perdita si avverte il baratro dell’assenza dell’altro, Un sogno chiamato Florida si tinge di rosa sul rosa, raccontando l’amore di una madre, affatto pronta per essere tale , gonfia finalmente di lacrime e disperazione piuttosto che ribellione e sconsideratezza.
Ad impreziosire un progetto tanto raffinato quanto grezzo e nudo quale The Florida Project è la presenza sul set di un colosso come Willem Dafoe, che se in prima battuta rischia di invalidare la funzione non-fingente e mokumentaristica del film, si rivela un jolly cantastorie, un mediatore di vite quasi-vere.
Senza strappare in alcun modo i meriti della buona riuscita a Baker, se il tutto funziona è merito della parte, in questo caso la fotografia. Alexis Zabé, che nel curriculum inserisce la manodopera fotografica di Stellet Licht di Carlos Reygadas, impalca un vero e proprio dramma dei colori. A dominare sulla scala cromatica dello schermo è il rosa, contrastato dal grigiore scuro delle strade, dal verde delle campagne che attorniano la periferia intera, colore della scoperta infantile dell’animale e del vegetale. Scontro cromatico che vede il rosa tenero come capro sacrificale, colorato e felice a dispetto di ogni situazione nera, in contrasto con i conti in rosso di tutti gli abitanti del Motel. Un rosa candido che riflette le torri Disney oltre il serpentone asfaltato trattenendo il sogno, solo il sogno, mentre muore in esso la dimensione fatata ancor prima della fine dell’infanzia.