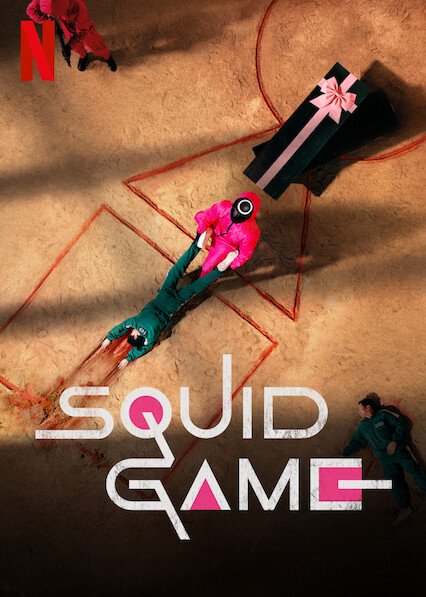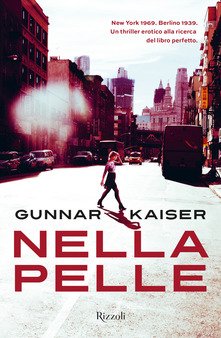Al cinema il caso di Billy Milligan che diventa il nuovo film di Shyamalan Split. Un racconto sospeso tra follia reale e qualcosa di poco più fantasioso.
Kevin ha dentro di se ventitré personalità differenti che si alternano passandosi la “luce” ciclicamente. Quando tre delle identità con tendenze estremiste prendono il sopravvento sulle altre comincia l’incubo per tre ragazze rapite nel parcheggio di un centro commerciale, destinate ad essere il pasto della bestia, ventiquattresima personalità sconosciuta anche alla dottoressa che studia il caso di Kevin.
Questa volta mi sono fidato di Shyamalan. “Con una storia così come fa a non fare un film memorabile?” mi sono detto. E poi questo caso di Billy Milligan, l’uomo dalle personalità multiple che ha violentato e aggredito alcune studentesse universitarie ha stregato un po’ tutti, compreso Leonardo DiCaprio che ,stando a quanto si dice in giro, sta preparando un film sullo stesso materiale. Attendiamo.
Ma è di Split che parliamo, il film che si pone a metà tra la terza stagione di Hannibal e il capolavoro di Hitchcock, Psyco, esasperando però i propri punti di partenza. Bravo Shyamalan nel costruire le varie identità, caratterizzandole in modo minuzioso, riempiendole con quei dettagli che solo l’ottima interpretazione di McAvoy avrebbe potuto riflettere sul grande schermo, quest’ultimo che fa da unico garante all’intera confezione per il raggiungimento stentato della sufficienza e che tutto sommato non ci fa mancare troppo Norman Bates. Nell’idea proposta da Split si è proprio ciò che si crede d’essere. Pensare d’essere una donna o un leone non entra in collisione con la la propria struttura fisica di partenza: un ordinario corpo da essere umano.
Il problema è che Shyamalan, nel costruire il suo mostro forgiato dalle piaghe dei dolori d’infanzia, ha finito per prendersi sul serio, trasferendo la totale follia di un uomo che andrebbe rinchiuso a vita (con tanto di chiave gettata nelle fogne) in una figura leggendaria, da iconografia medievale, che sbrana, salta, morde e soprattutto non muore. L’amore del regista per la sua creatura è impressa con forza sintetica all’interno di quel pàthei màthos scevro e svuotato dalla profondità di una tragedia greca, di cui è stato preso solo il guscio, un dolore che finisce per divinizzarsi ma in modo autoreferenziale, che lascia a noi spettatori solo il farfugliare un po’ “emo” di uno squilibrato con un passato difficile. I ritmi sono quelli giusti, ma il restare con i piedi di piombo avrebbe garantito al bistrattato regista de”Il sesto senso” di portare a casa risultati migliori, poco più razionali.
Le figure femminili sul set, specchio snodato e multiforme della vecchia madre che brutalizzava il povero Kevin, sono a dire il vero quasi del tutto consumate dalla presenza , pardon, presenze che animano le brutte stanze in cui “i folli” le tengono rinchiuse. C’è una Anya Taylor-Joy che già ci fa provare nostalgia per quel senso di pura malignità sovrana che vive in The Witch, attrice che qui quasi fa finta di ripetere quello che ha letto sul copione.
Quasi non meriterebbe d’essere preso in considerazione il finale auto-citazionista con cui Shyamalan interseca le sue stesse trame facendo comparire David Dunn (Bruce Willis) direttamente dal set di “Unbreakable”, lasciando ipotizzare qualcosa di simile ad uno spin-off/sequel o quel che sarà. Male, quasi malissimo.